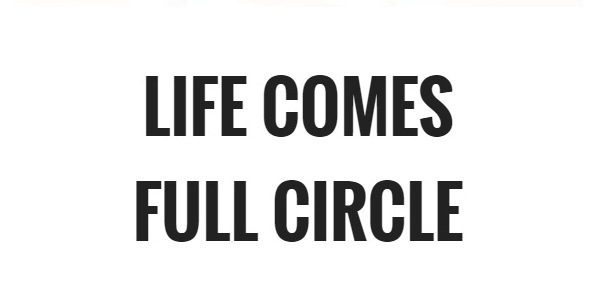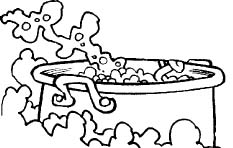È arrivato il tanto agognato Settembre!
Ed è anche arrivato il momento di riappropriarmi del mio blog, ché ho dovuto pagare fior fior di sesterzi per rivederlo in funzione!
Bando alle ciance mattutine di un sabato qualunque di Settembre, impugno la mia immaginaria penna e comincio a descrivere, senza troppi dettagli, quanto successomi negli ultimi tempi!
A dire il vero apparentemente proprio nulla dall’ultima volta, ma dentro me sento un tumulto a volte incontrollabile che parte dalle viscere e spesso si muove attraverso i tubi digerenti, poi risale a solleticare le corde vocali sino a sfociare, in seguito ad un misto di contrazioni muscolari di diaframma, gola e bocca, in sonori vaffanciuffo e porci vari, alati per lo più.
Nel giro di poche settimane ho perso entrambe le nonne, le uniche rimastemi oltretutto visto che i nonni hanno avuto troppa fretta di andare via da questo mondo, e sono stata male a lungo.
Non riuscivo ad accettare, specialmente per la madre di mia madre, di non poterle più vedere e salutare… Ho scritto loro una lettera che forse pubblicherò in seguito. Ancora il senso di lacerazione è devastante per potermene liberare del tutto.
Ma tralasciamo per un po’ questo discorso triste per passare nuovamente a cose frivole e prive di valore: FB.
Ho deciso di disintossicarmene.
Questo stramaledetto social media è in grado di logorare anche le menti più solide e plagiarle, piegandole al proprio volere oscuro e contorto.
Molte delle persone che conosco o che mi gravitano attorno, mio malgrado, vivono in questa sorta di bolla continua la cui superficie iridescente costituisce un limite sottile, ma evidente, tra sé stessi nella realtà e all’interno della piattaforma sociale più discussa e chiacchierata del secolo.
Secondo il mio punto di vista, stiamo assistendo alla più grande disconnessione umana mai conosciuta, stiamo annegando dentro un mare di pixel e scambi pseudo intellettuali in contesti del tutto inconsistenti.
Ci stiamo facendo controllare volontariamente, dandoci in pasto per intero a qualcosa che, alla lunga, non riusciremo a controllare.
Per lo meno, io non sono in grado di placare il mio incazzo sociale quando sono abbastanza attiva nelle discussioni riguardanti, ad esempio, l’immigrazione o l’alimentazione. Mi incazzo, punto e basta!
Sì, è ovvio che il problema sta a monte e trova sede in questa mia piccola testolina di innocente gatto sornione, ma la fiera che ho dentro, quando esposta all’arma di distrazione di massa rispondente al nome di facebook, riemerge dagli abissi e mi si possiede con violenza.
Fortunatamente, prima di mettere mano alla tastiera, penso quattrocento volte alle parole adatte da snocciolare con il massimo distacco e cortesia, anche nelle occasioni in cui l’unica risposta sarebbe un gioioso “ardi assieme a tutta la stirpe“.
È una questione soggettiva, forse, ma questa mia continua mediazione tra me stessa e la me-stessa-di-fb ha cominciato a stancarmi. Persino i gruppi di cucina stavano cominciando a diventare metaluoghi di perdizione, angoscia e continui fracassamenti di ovaie.
La nostra società sta divenendo distopica, come già previsto da grandi menti come quella di Orwell e Pasolini, ed a noi poveri inetti non rimane che “guardare” o fare gli opinionisti senza competenza a tempo perso per acchiappare quanti più like da persone sconosciute, che rimpiazzano prontamente il calore delle persone in carne ed ossa.
La nostra totale incapacità di confronto emozionale e personale ha compromesso uno scambio genuino, spontaneo e lo si evince con emerita tristezza anche dalle foto pubblicate a fiumi sulle “seratone più belle dell’anno” o sulla bocca a culo migliore del mese.
Ma voltiamo pagina e dedichiamoci, appunto, alla fatica letteraria di Deborah Harkness, intitolata “Il libro della Morte e della Vita“.
Categorizzato come un libro fantasy dalle tinte dark, questo romanzo narra la storia di una studiosa di storia della scienza, Diana Bishop, la quale entra in possesso di un manoscritto antico ed incantato. La storia si preannuncia piena di soprese e ci sarebbero tutti gli elementi per un ottimo racconto cupo, misterioso e accattivante… se SOLO non ci fosse una stramaledetta storia d’amore strappapalle a rovinare tutta la vera magia!
Cosa mi è piaciuto:
Innanzitutto le ambientazioni nelle quali hanno luogo le vicende sono molto suggestive: il romanzo è infatti ambientato principalmente in Europa, tra l’Inghilterra e la Francia, luoghi che di per sé trasudano storia, evocano alla mente immagini di lontane battaglie, ballate ed intrighi di corte, rafforzandosi nelle descrizioni dei castelli decadenti che richiamano vagamente l’idea romantica che lega indissolubilmente amore e morte in una danza, prima lieve e poi calzante.
La lettura è scorrevole ed il lessico di facile comprensione.
La narrazione è abbastanza lineare e trova compimento in questo primo libro, chiaramente ideato per avere un seguito.
Cosa NON mi è piaciuto:
Premetto di non aver mai letto Twilight, in compenso ho guardato Buffy per tutta la mia adolescenza.
Se c’é una cosa che mi urta davvero i nervi, quasi come sbattere il mignolo sullo stipite del mobile, è l’amore impossibile tra l’umana ed il vampiro che diventa possibile di colpo, contro tutto e tutti, persino contro qualsiasi logica e buon senso.
Scompattiamo per un secondo questo grande blocco rappresentato dal legame amoroso tra i due.
Matthew è attratto da Diana perché lei è la prescelta, l’unica capace di ottenere il manoscritto senza il minimo sforzo.
Diana più volte lo rifiuta, percependolo come pericoloso, ma lui non demorde ANZI diventa più pressante, presente ed asfissiante, tanto che arriverà al punto di entrarle in casa mentre lei dorme.
Allora, questo a casa mia si chiama essere degli stalker e siccome il libro è indirizzato a giovani adulte (ma leggasi pure adolescenti), il messaggio che passa è totalmente sbagliato, ovvero che quando una donna ti rifiuta in realtá è solo perché vuole fare la preda.
Ragazzi miei cari, NO vuol dire esattamente NO, non mi sembra così difficile da comprendere. Ed anche voi donne e scrittrici del nostro tempo, BASTA con queste minchiate dell’amore nato dallo stupro o più in generale dalla violenza. Capisco che possa capitare, ma è un caso su quanti?!
Diana viene descritta come forte, determinata e capace di badare a sé, ma quando Matthew, il vampiro bello e maledetto, entra in gioco, qualsiasi suo rifiuto, anche e soprattutto se esplicito, viene disciplinato dalla volontá di lui.
Proprio a causa di questa sua forza caratteriale, Diana è un personaggio scomodo, pertanto la scrittrice americana ha ben deciso di dare al vampiro stalker e protettivo, ma allo stesso tempo famelico cacciatore, il ruolo di educatore.
Man mano che il racconto prosegue, Diana diventa nel contempo una supereroina piena di poteri iperperfetti ed allo stesso tempo un piccolo animaletto indifeso di cui tutti DEVONO prendersi cura, la volontà di lei si rivela votata con dovizia all’incontrovertibile risolutezza del vampiro-padre-padrone-stalker.
Potrei andare avanti a distruggere ogni minimo dettaglio di questa storia d’amore, addentrandomi nell’insidioso rapporto suocera-nuora, ma mi astengo perché lo trovo talmente ridicolo che è al limite del pensabile.
Le citazioni storiche sono spesso fumose, inesatte e collocate in maniera casuale nel testo. Una eclatante è quella in cui a Caterina de’ Medici viene affibbiato l’appellativo di “regina italiana”.
NO.
Al massimo è stata regina consorte e poi reggente di Francia, ma l’Italia vedrà la sua prima regina “italiana” nel 1861 e sarà Margherita di Savoia moglie di Umberto I!
Consiglierei questa lettura?
Ni. Se non avete di meglio da leggere, CERCATE ANCORA!